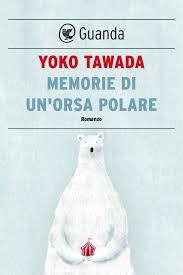(di Francesca Ferrara)
Io non sono del mestiere. Non ho studiato lettere e non ho propriamente trascorso l’adolescenza a divorare i classici della letteratura. Alle medie e alle superiori ero più vicina alla definizione di otaku, il corrispondente giapponese del nerd.
Considerando la maggior fruibilità del mezzo (almeno per me) e la biblioteca sterminata di traduzioni in inglese disponibile online, devo aver sfogliato più manga che romanzi nella mia vita. Perciò Kitchen (Feltrinelli, 1991) mi ha subito incuriosito per la sua quarta di copertina: “una rielaborazione letteraria dello stile dei fumetti giapponesi”.
In effetti, il libro d’esordio di Banana Yoshimoto può sembrare piatto e vuoto a chi non ha dimestichezza con i manga e con il genere shoujo in particolare. Una categoria rivolta ad un giovanissimo pubblico femminile e riconoscibile da alcuni ingredienti: amicizia, primi amori, ambientazione scolastica, uso raffinato di retini per chiaroscuri e per sfondi soffusi, linea di contorno sottile e uniforme, per figure senza peso.
Nonostante la componente romantica e sentimentale, Kitchen si distingue certamente per la sua forte carica drammatica: terreno comune dei personaggi, primari e secondari, è il lutto insieme alla solitudine che ne consegue. Una condizione vissuta in maniera diversa da Mikage e Satsuki, protagoniste rispettivamente di Kitchen e Plenilunio (o Kitchen 2) e di Moonlight Shadow, terzo capitolo e racconto di chiusura. Per la prima la solitudine è una condanna quasi custodita, per la seconda un’apatia da cui evadere.
Gli elementi shoujo però trionfano nell’estetica, nelle inquadrature e nella leggerezza della penna dell’autrice.
La luce è la regina dell’intero libro. Descritta in qualsiasi scena, che sia naturale o artificiale, e mai uguale. Su di essa vengono spese ben più parole che sull’ambientazione fisica, soltanto accennata, a marcare così l’atmosfera surreale e di sospensione che permea la lettura.
La luce è nutrimento agognato per chi non la possiede. Proprio così, è un attributo personale. Ci sono personaggi che irradiano luce propria, come Eriko, figura genitoriale e di supporto, e altri che possono solo vestirne il riflesso, come Mikage e Yuichi, ultimi superstiti delle rispettive famiglie. A loro non resta che muoversi nell’ombra, incontrandosi nella notte o nel tessuto onirico.
Allo studio minuzioso della luce si accompagna l’assenza di contatto. Con l’eccezione di una sola scena, i personaggi del libro non si toccano mai l’un l’altro. Così Mikage spiega il suo rapporto con Yuichi:
“Per ognuno dei due l’altro era sicuramente la persona più vicina al mondo, l’amico insostituibile. Tuttavia non ci tenevamo per mano. La nostra natura ci spinge a reggerci in piedi da soli, per quanto disperati possiamo essere.” (Pag. 63)
Quando presente, il contatto è aggressione, è morte; come nell’omicidio di Eriko o nell’incidente stradale che in Moonlight Shadow ha ucciso Hitoshi e Yumiko.
In questo racconto l’assenza della persona amata viene descritta in modo chirurgico – con quello che si offre, a mio parere, come un’infodump rispetto alla discrezione e al perfetto bilanciamento dei primi due capitoli – e il tocco fisico può esistere soltanto nei ricordi.
L’apice si raggiunge quando, in occasione del Tanabata (congiuntura astrale carissima ai lettori di shoujo), a Satsuki è concesso di rivedere l’amato, Hitoshi. I due non possono toccarsi né parlarsi, ma solo guardarsi per una manciata di secondi.
Banana Yoshimoto lascia raccontare ai suoi personaggi la desolazione e la silente disperazione del sopravvissuto che si trascina in ogni nuovo giorno. Eppure riesce a farlo importando e traducendo in parole il tratto distintivo del genere shoujo: la delicatezza.
Ci rendiamo conto che questa scelta di stile non ha intaccato la drammaticità del testo quando, in piedi sul ponte accanto a Satsuki, anche noi ci commuoviamo alla vista del suo compagno. Proiezione nella foschia sopra l’acqua del fiume, che la guarda “preoccupato, come sempre quando facevo qualcosa di irragionevole”, prima di sbiadire nell’alba e sorriderle “agitando la mano molte, molte volte” per salutarla (pagg. 128-129).
Banana Yoshimoto è una di quelle autrici che piace o non piace, senza vie di mezzo. Ma se leggendola vi ritrovate a nascondere occhi gonfi e labbro tremulo dietro la copertina, mentre tornate dal lavoro su un treno gremito, probabilmente rientrate nella prima categoria.