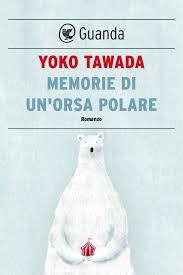(di Luciano Sartirana)
Ho letto Memorie di un’orsa polare, di Yoko Tawada.
Da una parte ci sono tre orsi bianchi, imparentati in verticale tra loro lungo decine di anni.
La prima era un’orsa che si esibiva in un circo sovietico, una vera diva della corsa, del salto e del lazzo fra bambini e funzionari di partito. Una volta che il suo corpo grosso non l’assecondava più nella sua vita di lustrini, si è messa a scrivere la sua autobiografia e ha sfondato anche lì.
La seconda è la figlia Tosca, che nasce rocambolescamente in Canada e si trasferisce nella DDR ripercorrendo le tracce della capostipite: volteggia in un circo, soprattutto come ballerina di tango. Non viene raccontata dalla sua penna (!!!), ma dall’addestratrice Barbara con la quale ha un legame pressoché simbiotico.
Il terzo è Knut, che rinuncia a velleità d’arte ma – una volta capito cosa ha da guadagnarci in termini di cibo e benessere – diventa la mascotte dello zoo di Berlino, assecondando i babbei che si assiepano per osservarlo.
Una cosa li accomuna: nessuno di loro è mai stato al Polo Nord, e neanche nei suoi paraggi. E un’altra, più profonda… la vicinanza con gli umani fa sì che ne assumano le mosse, i desideri di successo (la scrittura), i sogni, le frustrazioni, le manie. Decisamente ricambiati, perché anche gli umani che li frequentano non sono tanto diversi; e spesso il racconto, lo stile, il monologo interiore come le ansie da artisti ce li fanno confondere e porre sullo stesso piano precario: vogliamo grandi cose, per noi e per chi amiamo; ma viviamo tutti sotto l’incubo del disastro ambientale e della reciproca schiavitù quotidiana.
Una favola surreale apparentemente giocosa, comunque priva di ogni leziosità o carinerie (“se guardi un orso negli occhi non ci vedi un bel niente…”, si dice a un certo punto). Una grande riflessione filosofica sotto forma di gita tra gli anni, i circhi, i regimi e lo scrivere.
Yoko Tawada è nata a Tokyo nel 1960 e vive in Germania dal 1982, prima ad Amburgo e oggi a Berlino. Scrive sia in giapponese che in tedesco. Questo è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.