(di Marcella Valvo)
La prima opera di Stefano Benni che ho letto è stata Margherita Dolcevita, romanzo del 2005, la cui lettura risale ormai ai miei dodici-tredici anni. Purtroppo, benché sia stato subito amore a prima lettura, non ho più letto niente di suo – rimproverandomi regolarmente per il misfatto. Poi finalmente, pochi giorni fa, mi è capitato tra le mani Il Bar sotto il Mare, una raccolta di racconti in puro stile Decameron: e come un marinaio attirato dal canto della sirena, non ho potuto non afferrare il libro al volo e divorarlo.
Il genere dei racconti brevi si presta in realtà agevolmente a diversi ritmi di lettura: si può leggere tutto d’un fiato, o un racconto al giorno, magari prima di andare a dormire oppure durante qualche spostamento in treno o in metro. Questo, tuttavia, non sono riuscita a diluirlo. Ogni racconto mi chiamava inesorabilmente a quello successivo. Una ciliegia tira l’altra, si dice: in tal caso, Stefano Benni scrive ciliegie.
La cornice fin da subito porta il lettore a immergersi – in tutti i sensi – nella dimensione surreale, assurda, ricreata dall’autore e dominante nei diversi racconti. Non solo la voce narrante esordisce dicendo “Non so se mi crederete”, generando subito l’allerta, ma prosegue con la descrizione di un vecchio signore elegante, con una gardenia all’occhiello, che lo supera lungo la riva del mare con un inchino e sparisce poi nelle acque. Naturalmente, il narratore non può che seguirlo, tuffandosi anch’egli e ritrovandosi davanti a un bar dall’insegna luminosa sospesa a pochi metri dal fondale.
Il barista mi fece segno di avvicinarmi. Aveva un’espressione ironica e il suo volto ricordava quello di un famoso interprete di film dell’orrore. Mi offrì un bicchiere di vino e mi appuntò una gardenia all’occhiello.
– Siamo lieti di averla tra noi – disse sottovoce. – La prego di accomodarsi, perché questa è la notte in cui ognuno dei presenti racconterà una storia.
(Prologo)
Sempre all’interno del prologo che introduce la cornice, assistiamo a una rottura della quarta parete, con il narratore che si rivolge al lettore segnalandogli la copertina del libro stesso, cui far riferimento per capire l’eccentricità dei ventitré avventori del bar. E in effetti l’illustrazione di Giovanni Mulazzani ci rende un perfetto quadro del gruppo: dall’uomo col cappello al vecchio con la gardenia, dal bambino serio al nano, dall’uomo invisibile a quello con la cicatrice, dal cane nero alla pulce che abita il suo pelo… come se non bastasse, i ritratti di tutti questi personaggi si ispirano chiaramente a protagonisti del cinema e della letteratura (vediamo John Belushi in The Blues Brothers, Agatha Christie, Sigmund Freud, Marilyn Monroe, Braccio di Ferro…) e questo anticipa un altro particolare interessante dell’opera, ossia la sua ricchezza di riferimenti intertestuali. Ogni racconto, infatti, si caratterizza per un differente genere e una diversa modalità di narrazione, così che si passi dall’assurdo alla satira, dall’horror al giallo, con plurimi richiami a specifici autori e opere.
– Come lo sai?
– Me lo hai detto tu. Ti vanti spesso delle tue parentele, dottor Lollis. Ecco un altro sassolino che mi è tornato in mente. Due settimane fa tu leggevi questo libro, nell’intervallo in giardino. Allora non mi sembrò strano. Anch’io mi porto a scuola Poe e la zia Agatha… lo hai preso in prestito dalla biblioteca della scuola, vero?
(Priscilla Mapple e il delitto della II C)
Il risultato è un’opera eterogenea che lascia in bocca un sapore differente per ogni racconto, con il retrogusto di un risvolto moraleggiante che tuttavia non si impone mai. Questo perché Benni, pur spingendo alla riflessione, riesce sempre a mantenersi ironico e leggero, sottile e divertente.
Non posso che consigliare a voi questa lettura e promettere a me stessa di non far passare più così tanto tempo prima di rileggere qualcos’altro di suo.
Nonno Celso disse che ne avremmo viste di belle.
Bene, a febbraio era già primavera. Tutte le margherite spuntarono in una sola mattina. Si sentì un rumore come se si aprisse un gigantesco ombrello, ed eccole tutte al loro posto.
Dagli alberi cominciò a cadere il polline a mucchi. Tutto il paese starnutiva, e arrivò un’epidemia di allergie stranissime: ad alcuni si gonfiava il naso, ad altri spuntava una maniglia. La frutta maturava di colpo: ti addormentavi sotto un albero di mele acerbe e ti svegliavi coperto di marmellata.
(L’anno del tempo matto)



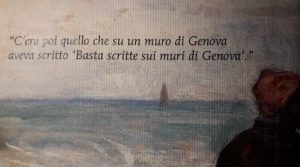

 Mentre eravamo lì, io con le mie foto e tu con i tuoi pupazzetti, ti sei voltata a guardare un’immagine sul mio computer, per due secondi o tre. Era la foto di un bambino su un autobus mentre guarda da un finestrino chiuso. Il bambino era in collo alla mamma, che aveva un velo in testa. Accanto a loro un uomo, penso il babbo. Tu, Caterina, ti concentri sul bambino e mi chiedi l’ovvio: “È un bambino?”
Mentre eravamo lì, io con le mie foto e tu con i tuoi pupazzetti, ti sei voltata a guardare un’immagine sul mio computer, per due secondi o tre. Era la foto di un bambino su un autobus mentre guarda da un finestrino chiuso. Il bambino era in collo alla mamma, che aveva un velo in testa. Accanto a loro un uomo, penso il babbo. Tu, Caterina, ti concentri sul bambino e mi chiedi l’ovvio: “È un bambino?”
