(di Marcella Valvo)
Pier Paolo Pasolini nacque a Bologna, ma si spostò frequentemente a causa della vita allo sbando del padre. La storia dello scrittore e della sua terra è una storia di arrivi e ripartenze. Anche la regione in cui trascorse la maggior parte del tempo, il Friuli, venne abbandonata, per sfuggire alle accuse di omosessualità.
E così Roma divenne la sua nuova casa, dopo un impatto con la città che lo segnò per la vita. Le tracce di questo incontro sconvolgente, impresse a fuoco nel suo animo, sono riversate in un romanzo (nonché il primo) fortemente sperimentale dell’autore: Ragazzi di vita, pubblicato nel 1955.
Non solo un libro che racconta una storia di ragazzi qualunque. Non solo un insieme di avventure, all’apparenza frammenti di esistenze. Ma anche un grido d’odio, anche una denuncia necessaria e inevitabile. Cosa, o chi, denuncia Pasolini? Lo scrittore si erge in lotta alle costrizioni della vita quotidiana e ai condizionamenti della società: tutto ciò che non gli permette di essere chi è e da cui sente di essersi liberato proprio lì, in quella città bellissima e disperata. Tramite una serie di racconti che vedono protagonisti i giovani borgatari romani – tutt’altro che bravi ragazzi! – Ragazzi di vita vuole rappresentare la realtà sociale della periferia della capitale, negli anni seguenti al regime fascista. Anni neri che hanno segnato indelebilmente la città e i suoi abitanti. Non c’è un protagonista soltanto: protagonisti sono i ‘ragazzi di vita’, ciascuno portatore di vita, o meglio di una ‘vitalità disperata’.
Il romanzo in realtà, si apre con un punto d’osservazione particolare: come una telecamera, le pagine inseguono il giovane Riccetto nelle sue imprese, mostrandoci la sua fame di vita e allo stesso tempo la paura che si nasconde dietro di essa. Le corse a perdifiato nelle strade di periferia, i furti più o meno riusciti ai Mercati Generali, i bottini racimolati al Ferrobedò, i sogni ad occhi aperti in riva al fiume. Il Riccetto fa parte a pieno titolo della realtà della borgata. Solo in seguito, quando deciderà di voltare le spalle a quel mondo e al mondo dell’infanzia (l’unico a noi raccontato), solo allora l’obiettivo della telecamera si sposterà da lui per inseguire più da vicino gli altri ragazzi del gruppo: il Caciotta, il Lenzetta, Alduccio…
Ma ciò che leggiamo in questo romanzo non è solo la gioia del vivere liberi, senza costrizioni. La vitalità di questi ragazzi è profondamente, indissolubilmente, intrecciata alla violenza e, in ultima istanza, alla morte. Come a voler rappresentare la reazione repressiva della società, già dalle prime pagine troviamo la morte accidentale di una donna ai Mercati Generali, e a questa seguirà il suicidio di Amerigo, così come la tragica fine del povero Piattoletta, piccola figura tragica la cui fine ingiusta e crudele spezza il cuore al lettore, senza scampo.
Di momenti di ‘strappo’ è colmo il romanzo: momenti fugaci, spesso troppo brevi, che lasciano intravedere una tenerezza di fondo nello sguardo con cui questi ragazzi sono osservati. Certo non sono santi, ma nemmeno demoni. Sono giovani e in balia di una realtà che li culla come la madre o il padre che spesso non hanno conosciuto. Così Marcello, intenerito dai cagnolini di Zambuia, ne prende con sé uno: immensa è la dolcezza con cui se ne prende cura. E poi una delle scene più significative del romanzo: il Riccetto che si getta in acqua, durante una gita in barca sul Tevere, per salvare una rondine che rischiava di annegare. L’assenza di una risposta a Marcello, che avrebbe preferito vederla morire, non fa che confermare l’estremo bisogno (e desiderio) sepolto nel cuore di prendersi cura di se stessi e dell’altro.
Il Riccetto li aspettava seduto sull’erba sporca della riva, con la rondinella tra le mani.
– E che l’hai sarvata a ffà, – gli disse Marcello, – era così bello vedella che se moriva!
Il Riccetto non gli rispose subito.
– È tutta fracica, – disse dopo un po’, – aspettiamo che s’asciughi!
Ci volle poco perché s’asciugasse: dopo cinque minuti era là che rivolava tra le compagne, sopra il Tevere, e il Riccetto ormai non la distingueva più dalle altre.
Per questo non si può che concordare con le parole di Gianfranco Contini, un grande amico di Pasolini, che nella recensione a questo romanzo scrisse: ‘Non è un romanzo? Infatti è un’imperterrita dichiarazione d’amore’.






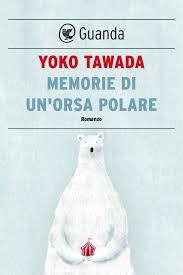

 (di Alice Borghi)
(di Alice Borghi)


